Aggiornato il 15 Dicembre 2025

Matteo parla in modo calmo, riflessivo, ma trasmette con tutto il suo essere una passione profonda per ciò che fa. Abbiamo incontrato Matteo Omilli, dottorando SST dell’Università di Trento in un pomeriggio d’estate, in collegamento dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento.
Matteo è un giovane ricercatore con un passato da architetto/ingegnere, un presente tra microstrutture e superfici antighiaccio, e un futuro brillante ancora tutto da costruire in una strana branca della scienza che si chiama “bagnabilità”.
In questa intervista ci racconta i suoi tanti e sorprendenti progetti scientifici e di come siano legati allo Spazio, ma soprattutto la sua visione della scienza come strumento umano, ispirato dalla natura e al servizio delle persone.
Partiamo dalla tua ricerca: di cosa ti occupi esattamente?
Immagina un drone che vola in alta quota per operazioni di soccorso, magari in ambienti montani: il freddo e il ghiaccio possono comprometterne seriamente il funzionamento. Il mio lavoro mira proprio a rendere queste tecnologie più resistenti, sicure, affidabili.
In particolare, lavoro nel campo delle superfici microstrutturate, su materiali antighiaccio: alla Fondazione Bruno Kessler stiamo sviluppando superfici che rallentano la formazione del ghiaccio e ne facilitano il distacco. Collaboriamo anche con EURAC Research, dove ho appena concluso una campagna sperimentale in camere climatiche capaci di simulare condizioni estreme: dai deserti più aridi alle tempeste d’alta quota.
La sfera di ricerca in cui i miei studi si inseriscono prende il nome di bagnabilità delle superfici, cioè la loro capacità di interagire con i liquidi: quanto un liquido aderisce, come si distribuisce o scorre su una superficie.
Questi fenomeni diventano ancora più complessi in condizioni di microgravità, come nello spazio, dove i liquidi non “cadono” ma si aggregano in modo imprevedibile.
Capire come controllarli è fondamentale in molte applicazioni spaziali, dalla gestione dei carburanti alla progettazione di rivestimenti funzionali.
Un ambito molto concreto. Da dove nasce questa tua passione?
Sembrerà assurdo ma tutto è iniziato con un coleottero del deserto della Namibia. Durante la mia tesi di laurea in ingegneria dell’architettura ho studiato come questo insetto riesca a sopravvivere in un ambiente aridissimo, catturando l’acqua dalla nebbia grazie alla forma del suo esoscheletro. Ho progettato una struttura architettonica ispirata a lui che non sono mai riuscito a realizzare praticamente, se non in forma di progetto, ma che mi ha permesso di capire una cosa fondamentale: la natura è una miniera inesauribile di soluzioni, un linguaggio da interpretare. Mi ha profondamente emozionato. Ho sentito il bisogno di approfondire quel linguaggio e così sono arrivato alla ricerca.

C’è anche una seconda fonte di ispirazione alla tua tua ricerca sulla bagnabilità, che viene da luoghi ancora più sperduti, giusto?
Sì. Studio superfici ispirate alle spine di un cactus andino. Questo cactus ha la capacità di far convergere gocce d’acqua lontane, grazie a microstrutture che guidano il fluido a riunirsi, le gocce più piccole microscopiche corrono verso le più grandi fino a convergere verso il corpo centrale della pianta.
È un meccanismo microscopico ma affascinante, che si può riprodurre con tecnologie avanzate di microstrutturazione disponibili alla Fondazione Bruno Kessler.
Lo scopo è quello di ottimizzare la raccolta dell’acqua in ambienti estremi, come deserti o ambienti privi di gravità. Ma le applicazioni sono tante: architettura, sensoristica, agricoltura. La natura, se la ascolti, ti offre tecnologie testate da milioni di anni.
Il dottorato SST è davvero così diverso dagli altri?
Sì, decisamente. È un dottorato nazionale, e questo significa che siamo sparsi in tutta Italia, ma connessi. Ogni anno ci incontriamo in una città diversa, grazie agli SST Days, e lì nasce un confronto reale: tra approcci, tra università, tra visioni.
Abbiamo anche più risorse, più fondi per partecipare a conferenze e lavorare con strumenti avanzati. Ma soprattutto, abbiamo libertà: la possibilità di dare una direzione personale alla nostra ricerca. Per me, questo è impagabile.
Inoltre non c’è argomento più multidisciplinare dello Spazio e nel dottorato c’è una grande varietà di approcci: chi fa diritto, chi astrofisica, chi ingegneria, e questo ti costringe a spiegare bene il tuo lavoro anche a chi viene da altri mondi. È una palestra di capacità di lavorare in team, una palestra umana ma anche di comunicazione scientifica.

Come ti immagini nel futuro?
Me lo chiedo spesso. Vorrei riuscire a unire le mie due anime, quella dell’architetto e quella del ricercatore. Magari progettare materiali intelligenti per l’edilizia sostenibile, oppure dispositivi per la gestione ambientale.
Ma più ancora, mi piacerebbe far parte di un gruppo affiatato , dove ci sia curiosità, rispetto e un senso etico del lavoro. Alla Fondazione Bruno Kessler pensavo che mi sarei trovato in un ambiente molto industriale e competitivo, invece ho trovato persone curiose, gentili, disponibili. E, soprattutto, interessate a ciò che fai. Ho capito che questo aspetto relazionale è per me fondamentale: ogni persona porta un’esperienza unica, e può arricchire il tuo percorso. Vorrei lavorare in un gruppo che conserva questa ispirazione, magari focalizzato su uno stesso scopo scientifico.
Alla fine, ciò che mi guida è il desiderio di fare qualcosa che serva anche agli altri. La voglia di trovare un senso.
Hai scoperto anche la passione per l’insegnamento, giusto?
Sì! Durante il dottorato ho fatto da tutor in un corso di Scienza delle Costruzioni. È stata un’esperienza fantastica. Vedere gli studenti capire qualcosa grazie a te è un’emozione difficile da spiegare.
Insegnare ti costringe a rimettere ordine in ciò che sai, a renderlo trasmissibile, e questo dà un senso più ampio al tuo percorso. Forse insegnare è ancora più importante che fare ricerca, perché forma le menti di domani.
Che consiglio daresti a uno studente curioso, ma incerto sul futuro?
Di non farsi frenare dai dubbi. Di lasciarsi ispirare, anche da qualcosa di semplice come un insetto o una pianta. La natura per me è sempre stata fonte di meraviglia. E da quella meraviglia è nata la mia scelta di fare ricerca.
Non è vero che è tutto già scoperto. C’è ancora tantissimo da capire, da migliorare, da inventare. E chi ha passione, anche se viene da percorsi non “perfettamente scientifici”, ha il diritto e il dovere di provarci.
E secondo te, che ruolo dovrebbe avere la scienza nella società?
La scienza deve essere un valore fondante. Non solo per sviluppare tecnologie, ma per migliorare la qualità della vita. La ricerca cambia le nostre vite. Ma dobbiamo fare in modo che lo faccia nel modo giusto, mettendo sempre le persone al centro.
E dobbiamo anche imparare a raccontarla meglio. La scienza non è solo formule: è passione, bellezza, senso del futuro. Se impariamo a comunicarla con chiarezza ed emozione, allora potrà davvero diventare patrimonio di tutti.
Questo articolo è stato rilanciato:
dal magazine della Fondazione Bruno Kessler
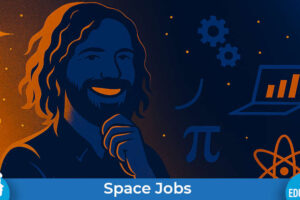


Add Comment