Comunicare la scienza e la ricerca significa, saperle guardare da due prospettive complementari: quella di chi le fa e quella di chi le racconta. Il Master in Comunicazione della Ricerca scientifica– ComRis dell’Università Roma Tre – a cui è possibile iscriversi fino al 31 dicembre 2025 – nasce proprio da questo doppio sguardo, come un’opportunità per chi vuole capire e vivere la scienza da entrambe le parti del dialogo.
Ce ne parla Elena Pettinelli, scienziata conosciuta a livello internazionale per la scoperta dell’acqua liquida nel sottosuolo di Marte, che l’ha proiettata al centro dei media e dell’attenzione pubblica mondiale. Pettinelli, fisica e docente all’Università Roma Tre, non è solo una ricercatrice di punta: è anche la fondatrice di ComRis.
Dalla sua esperienza e dalla collaborazione con un gruppo di professionisti della ricerca e della comunicazione è nata l’idea di un percorso unico — giunto quest’anno alla sua terza edizione — che mette insieme scienziati, giornalisti, comunicatori istituzionali e figure del settore privato per formare nuove generazioni capaci di raccontare la scienza in modo rigoroso, accessibile e coinvolgente.
Il master, di durata annuale, vede tra i partner alcune tra le principali realtà scientifiche e culturali italiane, come ASI, INFN, Thales Alenia Space, Città della Scienza, il Planetario di Roma, l’INGV, Explora e ovviamente l’INAF, ma anche numerosi professionisti provenienti del mondo dei media e della comunicazione istituzionale.

Professoressa Pettinelli, partiamo dall’inizio: com’è nato il Master ComRis?
Uno stimolo decisivo è stato il mio rapporto diretto con il mondo dei media: con i miei risultati su Marte improvvisamente mi sono trovata a gestire interviste -non sempre del tutto positive- con giornalisti italiani e internazionali, e ho capito quanto sia cruciale saper dialogare con loro. Da lì è nata la consapevolezza della necessità di una formazione specifica, che unisse ricercatori e comunicatori professionisti.
Il master è nato però anche come evoluzione naturale delle attività di divulgazione che già facevamo a Fisica, in particolare con le serate “Occhi su Giove, Occhi su Marte”, che negli anni hanno avuto un grande successo di pubblico. Quelle esperienze ci hanno mostrato quanto fosse importante saper comunicare bene: alcuni ricercatori riuscivano a catturare l’attenzione, altri meno. Così è maturata l’idea di strutturare percorsi che fornissero strumenti e tecniche per comunicare la scienza in modo efficace.
Credo che questo racconto ci permetta di sottolineare l’importante ruolo sociale che può avere un Università come Roma Tre per il territorio.
Assolutamente. Il nostro Dipartimento è cresciuto in un quartiere complesso, che l’università ha contribuito a trasformare e valorizzare. Abbiamo recuperato spazi industriali abbandonati, costruito un legame con i cittadini e riportato fiducia nella scienza.
Questo radicamento sociale si riflette anche nel master, che nasce da un rapporto diretto con la cittadinanza e dal desiderio di formare comunicatori capaci di instaurare un dialogo aperto, onesto e continuo con la società.
A chi si rivolge questo percorso di formazione post universitaria?
Le prime esperienze del nostro corso di laurea nel settore dell’insegnamento della comunicazione della scienza risalgono a oltre dieci anni fa, quando abbiamo introdotto moduli dedicati all’argomento per i nostri dottorandi e persino un corso universitario di Comunicazione e divulgazione scientifica per gli studenti di Fisica — un unicum nel suo genere.
Quando è nata l’idea di una formazione post-laurea, quindi del master, pensavamo inizialmente di seguire questi esempi e limitarlo ai laureati in discipline STEM. Ci siamo però resi conto molto velocemente che sarebbe stato un errore. Comunicare la scienza non è prerogativa di una singola formazione: servono filosofi, comunicatori, insegnanti.
Oggi il master è aperto a un pubblico molto ampio: ricercatori che vogliono migliorare nel public outreach, giovani interessati a diventare divulgatori e docenti che desiderano rendere più attrattivo e partecipato il loro modo di insegnare.
Imparare a comunicare bene significa avere più possibilità nella vita, qualunque percorso si scelga. E il master offre proprio questo: un’occasione unica per mettersi in gioco, lavorare in gruppo, confrontarsi con professionisti diversi e crescere molto, anche dal punto di vista personale.

Quali sono le caratteristiche distintive di questo percorso?
La sua formula didattica è unica: accanto ai docenti provenienti dal mondo della ricerca ci sono professionisti della comunicazione — dai giornalisti di Repubblica e della RAI fino a esperti di uffici stampa e del settore privato.
Questo intreccio di prospettive è il cuore del master: i corsisti non assistono solo a lezioni frontali, ma si confrontano direttamente con chi lavora ogni giorno nella comunicazione della scienza, imparando a scrivere articoli, gestire interviste, realizzare contenuti multimediali e affrontare i social.
E lo fanno anche in modo pratico: i 30 masterizzati che hanno completato le prime due edizioni del master hanno seguito degli stage in uffici comunicazione, redazioni, radio e musei scientifici — un’esperienza concreta che ha permesso loro di esplorare nuove professioni.
Un’altra caratteristica che colpisce è la forte presenza femminile.
Sì, ed è un aspetto che mi sta a cuore. Il master è nato da un gruppo in gran parte femminile, che unisce competenze scientifiche e comunicative. Non è un fatto scontato, soprattutto nelle discipline STEM, e penso sia un valore aggiunto che ispira le nuove generazioni.
In una delle nostre ultime riunioni ci siamo ritrovati a sorridere su un piccolo paradosso linguistico: secondo la grammatica, un uomo che ricopre il ruolo di vice di una direttrice -come nel caso del nostro master- dovrebbe essere chiamato “vicedirettrice”. Eppure, questa forma suona ancora davvero “strana”, quasi inaccettabile alle orecchie di molti. È una battuta, certo, ma anche uno spunto di riflessione su quanto la lingua continui a riflettere — e talvolta a rafforzare — i nostri stereotipi culturali.
Torniamo al ruolo del comunicatore scientifico nella società di oggi: qual è la sua opinione?
Viviamo in un’epoca in cui i ricercatori hanno perso parte della loro autorevolezza sociale, e le fake news corrono velocissime sui social. Per questo è fondamentale formare figure capaci di comunicare in modo chiaro, rigoroso e coinvolgente.
Un buon comunicatore scientifico non si limita a spiegare: costruisce fiducia, affronta i dubbi, smonta le false informazioni e restituisce alla scienza il suo ruolo di riferimento. Perché tutti hanno diritto di sapere.
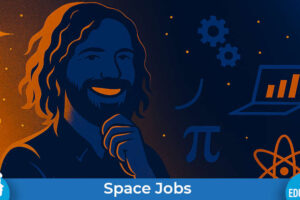

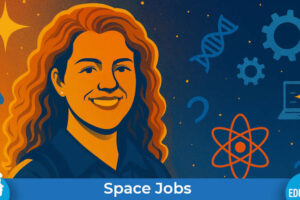
Add Comment