Aggiornato il 9 Ottobre 2025

Lucas Calzà ha proprio la faccia di uno che risolve problemi. O meglio, di un giovane fisico che sta imparando a risolvere quei problemi – veri, grandi – che influenzano la vita di milioni di persone e che si possono affrontare solo con la scienza, ma anche i problemi piccoli e quotidiani, come la voglia di continuare a costruire la propria vita e il proprio futuro scientifico rimanendo in quella terra meravigliosa che è la sua regione, il Trentino, dove si è laureato e dove sta seguendo il Dottorato nazionale in Scienze e Tecnologie Spaziali (SST).
Oggi Lucas, davanti allo schermo del suo PC dalle stanze dell’Università di Trento, si “accontenta” di fare il cacciatore di terremoti. Ovvero, studia i dati che arrivano da una missione spaziale cino-italiana che osserva l’atmosfera terrestre, provando a identificare quali tra i segnali anomali raccolti potrebbero essere collegati ai terremoti, con l’obiettivo – in un futuro che suona quasi fantascientifico – di riuscire a prevedere i moti della Terra e i loro effetti catastrofici.
In questa intervista ci racconta il suo percorso scientifico, ma anche le ambizioni e i desideri che accompagnano un giovane scienziato alla ricerca della propria strada tra accademia, industria e terra d’origine.
Lucas, partiamo dal tuo progetto di ricerca. Spiegaci bene di cosa ti occupi nel tuo dottorato.
Il mio progetto riguarda lo studio dell’interazione tra la litosfera e la ionosfera, in particolare per il monitoraggio dei terremoti. Utilizzo i dati di un satellite italo-cinese, CSES 01, a cui da poco si è aggiunto un secondo satellite, CSES 02. Lo strumento su cui lavoro misura elettroni e protoni lungo l’orbita. Io mi concentro sugli elettroni: analizzo il loro flusso in funzione del tempo e della latitudine, per cercare anomalie che potrebbero avere origine geofisica. In particolare, sviluppo algoritmi di machine learning per individuare questi picchi anomali e capire la loro natura. Per ora io mi sto concentrando sulla correlazione con i fulmini ma in prospettiva, l’idea di Roberto Battiston, lo scienziato dietro questa importante missione spaziale e coordinatore del Dottorato SST, è quella di monitorare se questi picchi siano correlabili con i terremoti. L’obiettivo in un futuro è quello di costruire un sistema di allerta automatica che, orbitando, segnali in tempo reale regioni di interesse.

Un tema ambizioso. Quanto è realistica l’idea di prevedere in futuro i terremoti dallo spazio?
Non è solo fantascienza, anche se serve molta cautela. Esistono modelli teorici, come quello sviluppato dal team italiano della missione che già ipotizzano un legame tra attività sismica e variazioni ionosferiche. Le evidenze di effetti esistono, ma non è detto che siano causali. Tuttavia, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale potremmo un giorno riuscire a distinguere segnali precursori da semplici coincidenze. Anche se non arrivassimo a una previsione vera e propria, poter individuare eventi anomali in tempo reale sarebbe già un grande passo.
Hai una formazione in fisica delle particelle. Come sei arrivato a lavorare su questo progetto?
Durante la magistrale ho scelto di fare la tesi – sempre con il Professor Battiston-, che mi ha introdotto al progetto CSES. All’inizio non ne sapevo molto, poi mi sono appassionato: è un progetto concreto, tecnologicamente avanzato, con un impatto potenziale molto forte, in cui posso essere utile. Così ho deciso di continuare con il dottorato. Io ho sempre avuto un approccio da “problem solver”. Risolvere problemi è ciò che mi piace fare, ed è anche ciò che mi definisce. Mi rendo conto che questa è una definizione molto ingegneristica, ma è così che vivo la scienza: come uno strumento per affrontare sfide reali. Se un giorno potessimo prevedere i terremoti con giorni o settimane di anticipo, cambierebbe la vita a milioni di persone.
Il dottorato SST è anche un percorso che ti ha aperto a contatti nuovi.
Sì. Io ho fatto tutto il mio percorso universitario, laurea triennale, magistrale e ora dottorato a Trento, quindi in un certo senso non ho mai lasciato casa. Ma il dottorato SST, essendo nazionale e interdisciplinare, mi ha messo in contatto con moltissime persone e realtà diverse. Gli SST Days a Palermo sono stati illuminanti da questo punto di vista: ho parlato con colleghi che si occupano di legge spaziale, biologia, ingegneria… È stata la prima volta in cui ho percepito davvero la dimensione nazionale e collettiva di questo percorso. Mi ha aperto la mente.

Hai detto di essere molto legato al Trentino. Come immagini il tuo futuro?
Io sto bene dove sono. Vengo da Arco, un bellissimo paese che si affaccia sul lago di Garda e, lavorando a Trento sono vicino alla mia famiglia, parlo la mia lingua, vivo in un contesto che conosco. Questo mi fa sentire tranquillo. Amo il posto dove sono nato e mi piacerebbe restarci, anche perché la mia regione offre molte possibilità ai giovani laureati in materie scientifiche. Ma so che la ricerca ha le sue regole. Il dottorato prevede un periodo all’estero, e io ne approfitterò -probabilmente andrò in Scozia -, imparando molto da questa opportunità, prima di tornare qui.
Nel frattempo il Dottorato mi offre molte opportunità per capire come proseguire il mio percorso: se mirare al mondo accademico o esplorare quello industriale. Il machine learning è applicabile a moltissimi settori, perfino per la finanza. Una laurea in fisica apre tantissime porte: non c’è solo la ricerca pura. E io ho non ho ancora deciso quale sarà la mia.
Mi tengo aggiornato, imparo a conoscere le aziende, valuto le opportunità. In questo senso, uno dei progetti che mi ha colpito e di cui faccio parte è”Space It Up”, promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di un’iniziativa nazionale che coinvolge università e aziende con l’obiettivo di far crescere la cosiddetta “New Space Economy” in Italia. Anche il nostro dottorato ne è coinvolto, ed è stato interessante vedere come queste connessioni possano diventare reali opportunità per noi dottorandi.
Che consiglio daresti a uno studente che oggi guarda al futuro con incertezza?
Di non avere fretta di sapere tutto. E di farsi ispirare dalle persone che possono indicarci la strada. Come ha fatto con me il Professor Battiston, che mi ha attratto verso lo spazio ancora prima che ne capissi le potenzialità. Ma non è stato l’unico. Alla fine del mio percorso liceale, quando ero ancora indeciso fino all’ultimo sulla facoltà da scegliere, è stata una mia professoressa a farmi notare quanto fossi migliorato in fisica, e da lì ho fatto la mia scelta. A volte serve solo una scintilla, una persona che ti dica: “sei bravo, prova”. E poi bisogna continuare a provarci. “If there’s a will, there’s a way”, dicono in inglese. Se c’è volontà, una strada si trova.
E per te, qual è il senso della scienza?
Ancora una volta, risolvere problemi. È una frase semplice, ma per me è tutto lì. La scienza è uno strumento per affrontare le difficoltà con metodo. Per esempio, non mi interessa per nulla tutto questo clamore intorno all’intelligenza artificiale usata per creare contenuti usa e getta. Ma mi affascina costruire una rete neurale da zero, vederla funzionare, usarla per analizzare i dati, per scoprire qualcosa di nuovo, per risolvere problemi. Questo è il tipo di scienza che mi appassiona: quella che funziona, che serve, che migliora la vita delle persone.
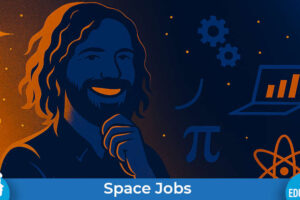

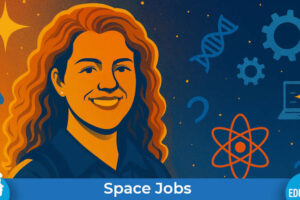
Add Comment