
Trentaquattromila visitatori unici, quattro padiglioni, oltre 3.000 tavoli da gioco esauriti: numeri da capogiro per la sedicesima edizione del Play – Festival del Gioco, che quest’anno ha debuttato nella nuova, scintillante cornice di BolognaFiere. E tra dadi, carte e miniature, c’era anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che ha portato l’universo sulla plancia da gioco.
L’area scientifica di PLAY si conferma un fiore all’occhiello dell’evento, facendo del gioco uno strumento di apprendimento: oltre 1500 studenti – arrivati da scuole di tutta Italia – sono stati coinvolti nelle proposte didattiche di sei Atenei italiani e dieci Istituti di ricerca scientifica e storica. Il Game Science Research Center, centro interuniversitario di cui Inaf, fa parte ha coordinato questo sforzo divulgativo e ha curato l’area talk: Uno spazio dedicato alla riflessione, alla ricerca e al dialogo sul gioco come oggetto di studio e strumento di cambiamento.

Un panel molto legato agli obiettivi del working group INAF su gioco, apprendimento creativo e tinkering è quello sull’uso del gioco per comunicare la scienza, per coinvolgere gli studenti e i cittadini nei dibattiti su temi scientifici sviluppando una cittadinanza scientifica attraverso il gioco. Michele Bellone ha aiutato me, Nico Pitrelli, direttore del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della SISSA di Trieste, Ennio Bilancini, professore di economia alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, a tessere connessioni tra strumento ludico e comunicazione della scienza a partire dal valore culturale del gioco e delle scienze.
Tra gli interventi più interessanti che ci riguardano, spicca l’incontro tra il MUSE – rappresentato da Christian Lavarian, Astronomy Area Manager – e l’INAF, con le ricercatrici ideatrici di PIXEL, che hanno messo a confronto approcci, esperienze e visioni comuni nel campo della divulgazione scientifica attraverso il gioco.
Stefania Varano dell’Inaf ha discusso con Proxima di larp (giochi di ruolo dal vivo) in contesti scientifici ed educativi, presentando The Null Hypothesis, un progetto congiunto per un larp alla Stazione radioastronomica di Medicina.
Sempre con Stefania un evento dedicato proprio a persone che si approcciano al design di giochi con Five Little Crows e Fumble GDR, dedicato agli elementi fondamentali del game design: ritmo, tensione e flow.
La commissione “equità nei giochi” del GSRC promossa da INAF con altre istituzioni del Centro, ha organizzato al PLAY un workshop con facilitatori di giochi per lavorare sulle buone pratiche di accessibilità e accoglienza e un momento di riflessione successivo con esperti, in cui vengono discusse queste buone pratiche.
Pixel, lo spazio in 8-bit

Protagonista indiscusso dello stand INAF è stato Pixel – Picture (of) the Universe, un gioco da tavolo competitivo che fonde astrofisica e strategia. I giocatori, nei panni di direttori di centri di ricerca, competono per la gloria scientifica. Come? Raccogliendo dati e investendo strategicamente risorse in personale, telescopi e missioni spaziali.
Il gioco si basa su una meccanica originale ispirata a un concetto chiave dell’astrofisica: la risoluzione delle immagini. I giocatori, utilizzando telescopi sempre più performanti, migliorano progressivamente la loro capacità di osservare il cielo, ottenendo immagini astrofisiche via via più dettagliate. Questo processo simula in modo fedele il funzionamento reale della ricerca osservativa, dove l’avanzamento tecnologico è cruciale per ottenere nuovi dati. Ma PIXEL non è solo un gioco di osservazione: è anche un profondo gioco di gestione risorse. Ogni partecipante veste i panni del direttore di un centro di ricerca astrofisica, e turno dopo turno – così come anno dopo anno nella vita reale – deve prendere decisioni strategiche sull’impiego delle risorse finanziarie per ottenere punti prestigio, obiettivo finale per la vittoria.
Il sistema è articolato e permette di trasmettere con efficacia la complessità del mondo della ricerca. Ad esempio, si può specializzare un ricercatore rendendolo un teorico: un investimento costoso, ma che accelera la produzione di pubblicazioni. Allo stesso modo, potenziare le infrastrutture, come l’officina tecnica, richiede risorse importanti, ma garantisce un ritorno notevole nel miglioramento dei telescopi.
È possibile reclutare giovani ricercatori dalle università, ampliando il numero di azioni disponibili a ogni turno, o puntare sulla produzione scientifica, investendo in pubblicazioni. Durante la partita, i punti prestigio si accumulano osservando il cielo, avanzando lungo tracciati di osservazione e portando a termine progetti specifici.
Il punteggio finale, però, non dipende solo dalla quantità di risultati, ma anche dalla coerenza con l’obiettivo di ricerca assegnato a ciascun giocatore all’inizio del gioco, collegato a uno degli oggetti celesti sulla plancia. Anche le pubblicazioni pesano attraverso due criteri: la varietà di pubblicazioni, ovvero se si è riuscito a pubblicare su più campi, e la specificità, ovvero il numero di pubblicazioni nel proprio settore principale. Ogni turno richiede una strategia flessibile, da ricalibrare in base agli eventi che si verificano nel gioco: un congresso internazionale, un guasto a un satellite, una nuova collaborazione scientifica o anche semplicemente condizioni osservative sfavorevoli. Questi eventi rappresentano le uniche componenti aleatorie del gioco, ma comuni a tutti i giocatori e aggiungono un elemento di imprevedibilità che richiama le sfide reali della ricerca astrofisica.

Come avviene per qualsiasi gioco commerciale, PIXEL è stato testato sul campo per garantirne la giocabilità e il bilanciamento. In più, stato anche sottoposto a un processo di validazione educativa, attraverso un percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) in cinque città italiane, coinvolgendo studentesse e studenti delle scuole superiori in un’esperienza ludico-formativa a tutto tondo.
Durante il percorso, i ragazzi non si sono limitati a giocare: hanno analizzato le dinamiche del gioco attraverso sessioni di debriefing, sviluppando competenze metacognitive e riflessive. Non solo: hanno anche condotto in prima persona sessioni di didattica ludica, facilitando partite per i loro coetanei e guidando momenti di discussione e confronto post-gioco.
Al termine di ogni attività, gli studenti hanno compilato un diario riflessivo, restituendoci dati preziosi sulla loro comprensione dei contenuti e sull’impatto formativo del gioco. In particolare, abbiamo voluto indagare se PIXEL fosse in grado di modificare la percezione della scienza e degli scienziati.
I risultati, attualmente sottomessi a una rivista scientifica e in fase di revisione, sono stati estremamente incoraggianti. Abbiamo osservato un passaggio significativo: da definizioni iniziali della scienza spesso rigide e scolastiche – centrate sul metodo galileiano – gli studenti sono arrivati, alla fine del percorso, a una visione più articolata e contemporanea della scienza, vista come un’attività collettiva, dinamica e intrecciata con le dinamiche sociali della comunità di ricerca. Ancor più significativo è stato il tono con cui hanno raccontato questa trasformazione: più personale, coinvolto e sentito. Il gioco non solo ha fornito strumenti di comprensione, ma ha acceso curiosità e interesse autentici.
Questa esperienza ci conferma una convinzione fondamentale: quando si costruisce un gioco per la didattica ludica, non basta curarne le meccaniche e garantirne la giocabilità. È altrettanto essenziale validarlo in contesti educativi reali, misurandone l’efficacia formativa e il potenziale trasformativo.
Tinkering in verticale: una pista delle biglie per giocare con la gravità
Allo stand INAF di Play 2025 non c’erano solo giochi da tavolo ma anche un artefatto ludico centrato sulle pratiche costruzioniste del tinkering: una pista delle biglie in verticale presente ormai da 7 anni nel nostro stand.

La pista invita i visitatori a sperimentare in prima persona concetti di fisica come gravità, velocità, attrito ed energia potenziale, costruendo e modificando il percorso delle biglie in modo creativo e collaborativo.
Abbiamo scelto il tinkering perché promuove un apprendimento attivo, esplorativo e aperto, perfettamente in linea con la nostra idea di scienza come processo dinamico e collettivo. Costruire, provare, sbagliare, aggiustare: sono azioni che raccontano esattamente come funziona la ricerca scientifica. Il tinkering, insomma, è un modo per scoprire il mondo giocando, e allo stesso tempo allenarsi al pensiero critico e alla cittadinanza scientifica.
In un’epoca in cui serve più che mai immaginare soluzioni creative e personali a problemi complessi, portare il tinkering dentro festival, scuole e musei ci sembra non solo utile, ma necessario.
Se ve lo siete perso non vi preoccupate! C’è già un appuntamento fissato per il prossimo anno: PLAY2026, dal 10 al 12 Aprile. Se volete venirci a trovare con la vostra classe o saperne di più scrivete a educational@play-festival.it

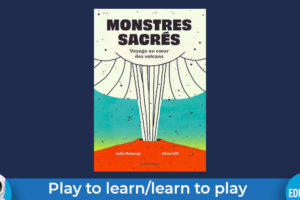

Add Comment