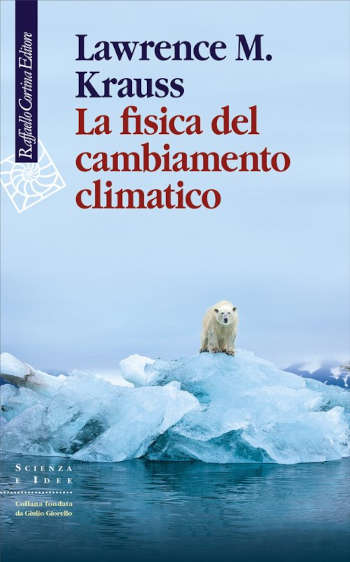 In un momento storico in cui la classe politica mondiale critica o sostiene le scoperte scientifiche in funzione della convenienza del momento, uno dei campi in cui maggiormente continuano a esserci forti dibattiti è la climatologia, in particolare lo spinoso problema dei cambiamenti climatici. Spesso sia la posizione negazionista, sia quella attivista, e a volte anche quella intermedia degli scettici (che arrivano ad accettare il fenomeno, ma mettono in discussione l’entità dell’apporto antropico), viene raccontata con toni estremi che alla fine hanno come unico effetto quello di polarizzare le posizioni, annullando la discussione ragionata e, quindi, impedendo alle persone di farsi un’opinione basata sui dati scientifici. Ed è proprio con quest’ultimo scopo che Lawtence Krauss, fisico e divulgatore, famoso in particolare per La fisica di Star Trek, ha deciso di redarre, a cavallo della pandemia del covid-19, un volume per raccontare nel modo più obiettivo possibile come il clima sulla Terra sta cambiando.
In un momento storico in cui la classe politica mondiale critica o sostiene le scoperte scientifiche in funzione della convenienza del momento, uno dei campi in cui maggiormente continuano a esserci forti dibattiti è la climatologia, in particolare lo spinoso problema dei cambiamenti climatici. Spesso sia la posizione negazionista, sia quella attivista, e a volte anche quella intermedia degli scettici (che arrivano ad accettare il fenomeno, ma mettono in discussione l’entità dell’apporto antropico), viene raccontata con toni estremi che alla fine hanno come unico effetto quello di polarizzare le posizioni, annullando la discussione ragionata e, quindi, impedendo alle persone di farsi un’opinione basata sui dati scientifici. Ed è proprio con quest’ultimo scopo che Lawtence Krauss, fisico e divulgatore, famoso in particolare per La fisica di Star Trek, ha deciso di redarre, a cavallo della pandemia del covid-19, un volume per raccontare nel modo più obiettivo possibile come il clima sulla Terra sta cambiando.
Al netto dell’immagine scelta dall’editore italiano per la copertina del volume, Krauss inizia il viaggio dal delta del fiume Mekong, in Cina, promettendo al lettore di spiegare come questa parte del mondo possa diventare una cartina al tornasole dei cambiamento climatico in atto. In effetti, come deducibile dai dati ottenuti con vari sistemi (su tutti il carotaggio di ghiacci e terreni), il clima della Terra è stato soggetto a varie variazioni nel corso dei millenni, ma in particolare il periodo di riscaldamento globale che stiamo attraversando deve accendere la nostra preoccupazione essenzialmente per via del contributo antropico cui scrivevo qualche riga sopra. Per arrivare a stabilire l’entità di questo contributo Krauss parte, però, dai fondamentali.
E già qui il fisico si distingue rispetto ad altri autori che trattano lo stesso argomento: non parte dal famoso grafico a mazza di hockey di Phil Jones e Raymond Bradley che tante polemiche ha generato, sia all’interno della comunità dei negazionisti, sia tra i climatologi stessi, ma utilizza dati decisamente più solidi, fornendo non solo delle spiegazioni convincenti sulla loro solidità, ma fornendo dei riferimenti precisi che il lettore più volenteroso può utilizzare.
La storia dello studio del clima
Una parte importante e corposa del libro è, però, dedicata alla storia del clima, che vede in Joseph Fourier il primo a interessarsi della faccenda: fu infatti proprio per capire meglio il contributo del Sole alla temperatura del pianeta che Fourier sviluppò lo strumento matematico delle trasformate di Fourier, da lui applicate alla diffusione del calore e oggi utilizzate in molti altri campi.
Altro grande pioniere dello studio del clima fu William Herschel, grazie alle sue precise osservazioni del Sole, senza dimenticare il fondamentale contributo di John Tyndall, i cui lavori posero le basi sperimentali per l’enunciazione del famoso effetto serra.
Alla fine di questa piccola catena storica troviamo il chimico-fisico svedese Svante Arrhenius, premio Nobel nel 1903, che non si interessò solo dello studio dei processi energetici dietro le reazioni chimiche, ma propose anche alcune idee che oggi sono presenti nella teoria della panspermia. E ovviamente approfondì anche la questione dell’effetto serra. Su questo argomento sono significativi due fatti: il primo è che le predizioni sulla crescita dell’anidride carbonica e della temperatura superficiale che fornì Arrhenius erano compatibili con l’aumento di anidride carbonica legata alle prime attività industriali. In pratica si ha la sensazione che se gli esseri umani avessero mantenuto quel livello iniziale di industrializzazione, la temperatura media sul pianeta non sarebbe aumentata in maniera apprezzabile rispetto agli inizi del XX secolo. Il secondo fatto, che è più una curiosità (anche se a leggerla oggi è quasi inquietante, se consideriamo un classico della divulgazione climatica come A qualcuno piace caldo di Stefano Caserini), è che lo stesso Arrhenius auspicava un aumento di temperatura dell’ordine da lui previsto: qualcosa come 3-4 °C in 3000 anni.
La fortuna aiuta le menti preparate
E’ questo il sottotitolo dell’epilogo del libro di Krauss e riassume molto bene tutta l’essenza del volume. Krauss non vuole essere catastrofista, proporre alcuna dinamica in stile prima che sia troppo tardi, ma non nasconde la sua preoccupazione sul futuro del pianeta e del genere umano. La porzione del libro dedicata a ciò che ci aspetta, infatti, non è esattamente ottimistica, nemmeno con l’approccio distaccato adottato da Krauss. Infatti, dopo aver presentato i dati che, in maniera abbastanza inequivocabile, mostrano come le emissioni di anidride carbonica in atmosfera siano, oggi, per la maggior parte (per non dire la quasi totalità) di origine antropica, mostra al lettore quanto sia complesso il processo inverso. Soprattutto dal punto di vista tecnologico.
L’unica concessione in qualche modo emotiva che Krauss concede a se stesso sta, però, nell’epilogo, che diventa una specie di appello accorato al lettore, affinché non ignori ciò che sta accadendo oggi sul nostro pianeta. Ovviamente non a scatola chiusa, ma partendo proprio da quanto la fisica ci dice sui processi alla base del riscaldamento globale in atto nell’ultimo mezzo secolo o poco più.
Abbiamo parlato di:
La fisica del cambiamento climatico
Lawrence Krauss
Traduzione di Giuseppe Bozzi
Raffaello Cortina Editore, 21 aprile 2022
204 pagine, brossurato – € 18
ISBN: 9788832854237

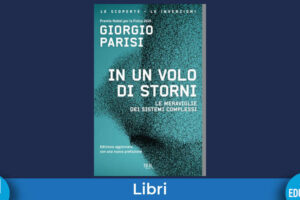
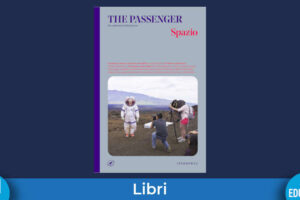
Add Comment