Aggiornato il 19 Settembre 2025

C’è un’idea persistente, quasi un mantra, che avvolge il mondo scientifico: l’idea che la scienza, per sua natura, sia un faro di oggettività, immune dalle storture sociali che affliggono il resto del mondo. Una sorta di “bolla neutra” dove il merito è l’unico metro e i pregiudizi semplicemente non attecchiscono. Ma è davvero così?
Di questo tema si è parlato al recente convegno Oltre i confini, il primo evento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dedicato all’inclusione, alla diversità e all’accessibilità nelle istituti di ricerca.
Grazie ai contributi di relatrici e relatori provenienti da importanti realtà nazionali che vanno dalla ricerca alla normazione fino all’attivismo, questo incontro ha messo in luce che le sfide dell’accessibilità e dell’inclusione nella ricerca non sono poi così diverse da quelle che incontriamo a scuola, in famiglia, o nella vita di tutti i giorni. Sono, in fondo, sfide umane.
Come ha racconta provocatoriamente e brillantemente Francesca Vecchioni, presidente di Fondazione Diversity, nel 96% dei casi siamo Homer Simpson, e il pensiero istintivo sovrasta quello logico e razionale. E in quelle percentuali, ahimè, ci finiamo anche noi, con le nostre intuizioni, i nostri automatismi, i nostri piccoli (e grandi) bias.

Ma quali sono i “confini” che la scienza, per crescere davvero, deve imparare ad abbattere?
Pensare che la scienza sia immune dai pregiudizi è certamente un grosso errore. I bias cognitivi sono ovunque, respiriamo stereotipi culturali, e questi influenzano il nostro sguardo e il modo con cui interpretiamo il mondo. Persino il concetto di “meritocrazia”, uno dei capisaldi del mondo della ricerca, va rovesciato. Vecchioni su questo punto è lapidaria: la meritocrazia vera esiste solo quando si parte tutti dalla stessa condizione, il merito ignora le disuguaglianze di partenza, privilegiando chi è già avvantaggiato. È una verità scomoda, ma sacrosanta.
E qui sta il punto: anche chi si dedica alla ricerca, pur con la sua innata propensione all’oggettività, è un essere umano. Ogni persona è soggetta a quegli errori sistematici del pensiero che possono portarci a favorire un’ipotesi solo perché la riteniamo “giusta”, o a dare per scontato ciò che, in realtà, andrebbe provato e riprovato. Pensiamo al confirmation bias: quante volte cerchiamo solo le prove che confermano le nostre convinzioni, ignorando quelle che le smentiscono? È un meccanismo insidioso, che nel mondo scientifico può rallentare, o addirittura distorcere, il percorso della scoperta. Per questo, la vera sfida è imparare a smontare le nostre certezze, a metterle in discussione.
Per esempio, quando si parla di disabilità, spesso ci fermiamo all’immagine della sedia a rotelle, alla rampa d’accesso. Valentina Tomirotti, però, con la sua esperienza di giornalista e attivista, squarcia il velo su un’altra dimensione: l’accessibilità non è solo fisica. È culturale, è tecnologica, è mentale. Un video senza sottotitoli per chi non sente, un software complicato per chi ha difficoltà cognitive, persino un telescopio il cui oculare è irraggiungibile per chi non può salire una scala: queste sono barriere, vere e proprie esclusioni.
C’è un dato che fa riflettere: negli Stati Uniti, le persone con disabilità rappresentano una percentuale irrisoria nella forza lavoro STEM. Perché? Non solo per le barriere architettoniche, ma per un pregiudizio sottile: l’idea che chi ha una disabilità non possa aspirare a certi ruoli, o che debba sempre “adattarsi”. Invece, come ci ricordano da più parti, basterebbe un po’ di creatività e di volontà: banchi regolabili, attrezzature parlanti, ambienti pensati per accogliere davvero tutti. È una questione di progettazione universale, ma ancor prima, di cambiare la nostra prospettiva.

E poi, c’è la questione della presenza femminile nelle STEM, un tema che, purtroppo, è ancora attualissimo. Se solo 66 premi Nobel su oltre 900 sono andati a donne, c’è qualcosa che non va. Non è questione di intelligenza o capacità, ma di un sistema che, ancora oggi, fatica a liberarsi da stereotipi e discriminazioni. Roberto Baiocco, Professore Ordinario in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione alla Sapienza Università di Roma dove presiede anche il Comitato unico di Garanzia, mette il dito sulla piaga, parlando di quanto sia necessario decostruire sistemi escludenti. Il suo esempio dei “cessi liberati” nelle università è semplice e potente: un bagno sicuro e accessibile per tutte le identità di genere non è solo una questione di servizi igienici, ma di rispetto, di riconoscimento, di inclusione.
I bias inconsci, gli stereotipi culturali, le aspettative sociali: sono tutti elementi che, sin dall’infanzia, possono allontanare le ragazze dai campi scientifici. Lo vediamo nei libri di testo, che ancora oggi faticano a liberarsi da ruoli di genere fossilizzati, o nel linguaggio stesso, che spesso, senza volerlo, perpetua vecchie abitudini mentali.
Non si tratta solo di un problema di giustizia sociale, ma di una perdita economica e intellettuale per tutti. Immaginate quante scoperte, quante innovazioni, quante nuove prospettive si perdono ogni giorno perché il talento di metà della popolazione non viene pienamente espresso o riconosciuto.
Il processo è culturale, certo, ma passa anche per normative e certificazioni, come sottolinea Elena Mocchio di UNI, l’Ente Italiano di Normazione. L’inclusione e la parità di genere, oggi, non sono più solo “belle intenzioni”, ma veri e propri requisiti per accedere a finanziamenti europei, come i progetti Horizon Europe. La certificazione della parità di genere non è una medaglia da appendere al muro, ma un impegno concreto, una bussola per le istituzioni.

Un altro tema molto dibattuto è legato alla multiculturalità della scienza. L’INAF, con le sue molteplici collaborazioni internazionali, è un crogiolo di culture. Ed è lì che la sfida dell’inclusione si fa ancora più affascinante e complessa. L’esperienza di Marianna Kalonda Okassaka, creatrice di contenuti e responsabile del progetto ColorY*, racconta quanto possa essere difficile per una persona di seconda generazione, nata o cresciuta in Italia ma con una storia di migrazione alle spalle, anche solo immaginare un percorso nel mondo scientifico. Mancano spesso i mezzi economici, ma anche quel “capitale intergenerazionale” fatto di conoscenze, agganci, modelli che determina tante scelte di studi e carriera. Non parliamo poi delle mille difficoltà pratiche e burocratiche che deve affrontare una persona straniera, per quanto in possesso di un regolare contratto di ricerca o all’interno di un percorso ufficiale di studi, per poter svolgere il proprio lavoro.
E poi c’è il bias culturale, quello che ci porta a considerare più autorevoli le voci bianche, occidentali e in lingua inglese. La scienza, per sua natura, è universale; ma la pratica scientifica, spesso, è ancora troppo centrata sul mondo occidentale, eurocentrico e anglofono.
Un modo, senza volerlo, di tagliare fuori una fetta enorme di conoscenza, di prospettive, di modi di vedere il mondo e la scienza. E invece, un team di ricerca davvero multiculturale non è solo “politicamente corretto”, è più ricco, più creativo, più capace di porre domande nuove e di trovare soluzioni inaspettate.
Infine, ultimo ma certamente non meno importante in tema di diversità, è il modo con cui il mondo della scienza considera le neurodivergenze e i bisogni educativi speciali. Un mondo variegato e complesso, che va ben oltre la visione stretta di “disabilità”, come racconta Marco Pontis, pedagogista, docente presso l’Università di Perugia, autore e formatore per Erikson. Persone con autismo, ADHD, dislessia: menti che funzionano in modi diversi, e che possono offrire contributi straordinari alla scienza. Eppure troppo spesso il sistema accademico, con le sue lezioni frontali, i suoi esami standardizzati, i suoi ambienti rumorosi e sovra-stimolanti, diventa una barriera insormontabile.
Qui, la soluzione non è una taglia unica per tutti, ma un design universale per l’apprendimento: flessibilità nei curriculum, spazi silenziosi, strumenti di assistenza tecnologica. Si tratta di comprendere che una mente che “funziona diversamente” non è una mente “difettosa”, ma una mente che necessita di un approccio diverso per esprimere al meglio il suo potenziale. E la scienza, che si nutre di prospettive originali, non può permettersi di perdere queste voci.
La conclusione di Oltre i Confini è stata un invito all’azione. Ognuno può fare qualcosa nel proprio giardino, sono le parole di Tomirotti. Del resto, l’inclusione non è un evento straordinario, un progetto isolato. È un lavoro quotidiano, un cambio di mentalità, un modo diverso di guardare al mondo e alle persone.
Francesca Vecchioni ha sintetizzato in modo magistrale il punto: un team davvero diversificato non è solo “più giusto”. È più intelligente, più critico, più efficace. Affronta i problemi da angolazioni diverse, scardina i pregiudizi e, alla fine, ottiene risultati migliori. Per chi fa scienza, questo non è un dettaglio: è la chiave dell’eccellenza.
L’INAF, con questa iniziativa, ha lanciato un segnale forte: l’inclusione comincia da dentro. Dalle modalità di selezione, dagli ambienti di lavoro, dal modo in cui si racconta la scienza. Dal linguaggio inclusivo alle quiet room per chi ha bisogno di uno spazio tranquillo, fino alla stesura di un codice di condotta chiaro. Sono piccoli passi, certo, ma sono semi che, con cura e dedizione, possono far fiorire un futuro scientifico più plurale, più ricco, più vero. Un futuro dove ogni voce, ogni mente, ha la possibilità di contribuire a spingere l’asticella del sapere sempre più in là.

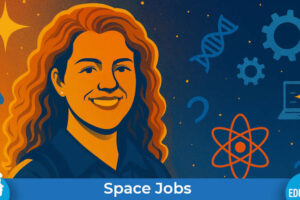

Add Comment