Aggiornato il 18 Settembre 2025

Quanto è davvero inclusivo un ambiente di ricerca professionale dove sono all’ordine del giorno collaborazioni internazionali, sfide peculiari, e l’incontro con la grande diversità del mondo? Come rendere il lavoro e gli ambienti della ricerca ancora più accessibili e accoglienti, dal punto di vista fisico, emotivo e culturale?
Tutte le realtà lavorative, superate le connotazioni e le specificità in termini di interessi, obiettivi e competenze, sono espressioni della società che le ospita. Questo significa, da una parte, che le esigenze e le difficoltà in termini di accessibilità e inclusione non sono diverse da quelle di un qualsiasi altro contesto sociale.
Per esempio ci sono, come ovunque, persone con disabilità dette “invisibili”, che non sempre emergono e di cui si fa fatica ad avere consapevolezza. D’altra parte, in Enti di ricerca pubblica come l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), con numerose collaborazioni internazionali, compaiono sfide peculiari, come l’incontro con la grande diversità del mondo, in termini di lingue, culture, tradizioni e abitudini sociali.
Succede però anche che a fare ricerca scientifica e in generale a lavorare in enti pubblici non si incontrino molte persone con disabilità motorie o sensoriali (ma inserendo qui altri assi di discriminazione probabilmente l’affermazione resterà vera), perché i muri della società creano barriere di cui a quel punto si vede solo l’effetto, rischiando di non riconoscere la causa. Quello che, però, è forse più interessante è che in ambiti professionali come quello della ricerca scientifica si sperimenti la sensazione che, dato l’alto livello culturale, l’ambiente di lavoro non sia toccato da questi problemi, come si fosse all’interno di una “bolla neutra”, lontana e irraggiungibile da problemi che sembrano socialmente più diffusi (come dicevamo in merito alla parità di genere nei luoghi di lavoro in una delle nostre interviste a Lorenzo Gasparrini). La chiave è proprio questa: non è così. Le questioni in gioco sono le stesse e le problematiche pure, anche se forse con sfumature specifiche. È necessario vederle, riconoscerle, capire come affrontarle.

Di questo tema si è parlato al recente convegno Oltre i confini, il primo evento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) dedicato all’inclusione, alla diversità e all’accessibilità nelle istituzioni pubbliche, in particolare nella comunità scientifica. Un’iniziativa che, dal 5 al 7 maggio 2025, ha riunito a Bologna (con una piccola delegazione presente online) personale INAF da 16 sedi diverse, con l’obiettivo di rendere gli ambienti di lavoro “il più possibile accessibili e accoglienti, dal punto di vista fisico, emotivo e culturale”. Il meeting è stato organizzato dal gruppo UNIVERS@LL (per l’equità nella didattica e divulgazione dell’astrofisica), dal Comitato Unico di Garanzia e dal gruppo del Gender Equality Plan (GEP) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
Non solo “parole”
Il meeting ha offerto una panoramica generale della diversità che compone la nostra società, di come questa diversità esista anche negli Enti di Ricerca pubblica, e del perché a volte non esista quanto dovrebbe. L’obiettivo era quello di aumentare la consapevolezza sulle difficoltà che le persone che lavorano, o vorrebbero lavorare, in ambiti professionali di ricerca scientifica possono incontrare, individualmente o nell’interazione tra loro.
Il programma è stato concepito non solo come un momento di confronto sui temi dell’accoglienza e dell’accessibilità, ma anche come un esercizio pratico per metterli in atto. Il Comitato Organizzatore ha curato ogni aspetto dell’evento con questa sensibilità: dalla scelta dei temi e degli speaker all’uso di un linguaggio inclusivo e bilingue, fino alla verifica dell’accessibilità della sede e l’identificazione di soluzioni per rendere l’evento accessibile anche a chi, come il personale amministrativo, tecnico o tecnologico, di solito non partecipa a congressi o non dispone di fondi per la mobilità. Tra le pratiche adottate, anche la presenza di una quiet room — una stanza tranquilla in cui rilassarsi e prendersi una pausa — ormai sempre più diffusa come buona prassi nei congressi scientifici.

La prima parte del meeting ha ospitato una presentazione generale dei concetti di equità, accessibilità, diversità e inclusione da parte di Francesca Vecchioni, presidente della Fondazione Diversity, e una panoramica su normativa, progettazione europea e buone pratiche a livello nazionale e internazionale con Elena Mocchio dell’Ente Italiano di Normazione (UNI).
Durante il secondo giorno sono stati affrontati quattro temi: neurodivergenza, multiculturalità, genere e disabilità sensoriali e motorie. La discussione incrociata su queste tematiche ha coinvolto Marco Pontis dell’Università degli Studi di Cagliari; Marianna Kalonda Okassaka, italiana di seconda generazione, content creator e responsabile della piattaforma ColorY* per la condivisione e lo scambio tra culture; Roberto Baiocco, professore in psicologia dello sviluppo e dell’educazione alla Sapienza Università di Roma; e Valentina Tomirotti, giornalista e attivista.
A seguito della tavola rotonda, questi stessi temi sono stati trattati in una serie di workshop paralleli, nei quali sono state affrontate situazioni realistiche per la vita lavorativa in un ente pubblico di ricerca con l’approccio del problem solving, evidenziando anche cosa si sta già facendo nello specifico all’INAF su questi temi.
Oltre i Confini è stato un vero esperimento che vogliamo raccontare in dettaglio su EduINAF, con l’idea di farne l’inizio di una riflessione e azione continua all’interno dell’Ente, ma anche di trarre dall’esperienza una serie di buone pratiche, condivisibili ed esportabili in contesti analoghi.

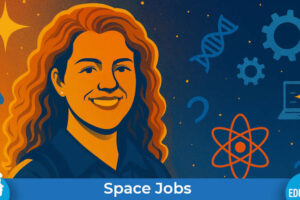

Add Comment